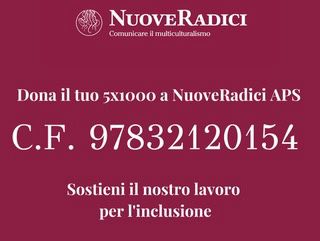In Italia sta nascendo una nuova generazione di professionisti dell’IT. I protagonisti arrivano come profughi da Paesi dilaniati da instabilità geopolitiche ma, nonostante le difficoltà delle loro storie personali, hanno i requisiti per inserirsi nel mercato del lavoro europeo. Se n’è accorto nel 2017 lo svizzero Christian Hirsig che ha deciso di lanciare un’accademia di programmazione per rifugiati, dopo un incontro illuminante con due imprenditrici statunitensi del settore della formazione professionale per migranti, attive nel coding (la programmazione, appunto) per donne e con una scuola di cucina. Ha preso forma così Powercoders, ong che dalla Svizzera è approdata a Torino nel 2020 e ha passato il testimone a Milano per l’edizione 2021, con il supporto di Reale Foundation, Fondazione Italiana Accenture, Lenovo, UNHCR Agenzia Onu per i Rifugiati e il Comune di Milano. L’ultima buona notizia è che anche le istituzioni italiane hanno riconosciuto il valore di Powercoders che, con l’adesione alla Repubblica Digitale, è ufficialmente entrata nelle iniziative strategiche nazionali promosse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Da rifugiati a generazione IT
A Milano i corsi sono partiti all’inizio di febbraio in versione online e andranno avanti per tre mesi. Sono rivolti a uomini e donne per la maggior parte provenienti da strutture di accoglienza come gli Sprar (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati). Non sono richieste competenze specifiche nel settore IT, anche se costituiscono un vantaggio, e sono invece tenute in grande considerazione motivazione, passione e determinazione, per evitare che ci sia dispersione di studenti. Elementi decisivi nei criteri di selezione dei Powercoders sono anche l’attitudine al problem-solving, la creatività e naturalmente la conoscenza delle lingue italiana e inglese. «Abbiamo scoperto un’alta scolarizzazione dei partecipanti che smentisce quello che ci raccontano i media del rifugiato emarginato. Quest’anno il cinquanta per cento dei partecipanti ha una laurea triennale e il resto un diploma di scuola superiore» ci spiega Chiara Maiorana, responsabile della comunicazione per il progetto. «Per quanto riguarda la partecipazione femminile, la percentuale di donne è ancora bassa ma siamo molto felici che nell’edizione attuale il numero sia raddoppiato, passando da due a quattro».
Il corso è gratuito e per un numero limitato di studenti è anche prevista una borsa di studio, ma i partecipanti si impegnano a rimborsare l’accademia con una percentuale una volta trovato un buon lavoro, in una sorta di catena virtuosa che andrà a sostenere i Powercoders di domani
L’inserimento nel mercato del lavoro
Durante la formazione i partecipanti acquisiscono competenze sia tecniche sui linguaggi di programmazione, sia trasversali riguardanti l’ambito sociale, le cosiddette soft skills, in modo da raggiungere una preparazione a 360 gradi all’ingresso nel mondo del lavoro. «Il nostro obiettivo è creare professionisti che rispondano alle reali esigenze del mercato. Per questo motivo a metà corso dedichiamo una settimana agli incontri tra i partecipanti e le aziende interessate ad attivare tirocini retribuiti una volta terminata la formazione. Così, nell’ultima parte del corso abbiamo gli elementi per concentrarci sulla definizione delle competenze che effettivamente le aziende richiedono e chi esce da Powercoders può essere competitivo sul mercato». Ma i tirocini non sono scontati, precisa Maiorana, la loro attivazione dipende dalle capacità dei partecipanti e dalle opportunità concrete che nascono con le aziende. Per rendere più mirato il percorso dell’inserimento lavorativo, i Powercoders vengono seguiti da job coach prima e durante i tirocini. «Nel 2020 sono stati attivati 12 tirocini su 20 partecipanti, di cui 10 si sono trasformati in contratti di lavoro di apprendistato».
Le storie dei powercoders
Tra i Powercoders dell’edizione di Torino ad avere firmato un contratto, c’è Asem Alakabani, che ora è junior technical consultant per la società Aubey. Trentenne, siriano, dopo due anni in Libano è arrivato in Italia tre anni fa tramite i corridoi umanitari, stabilendosi a Torino dove ha ottenuto la protezione per cinque anni. «In Siria mi sono diplomato ma poi la mia vita si è fermata nel 2010, quando mi hanno chiamato per il servizio obbligatorio nell’esercito. La rivoluzione siriana è iniziata nel marzo 2011 e tutto è cambiato, la gente non poteva neanche uscire. Io ho preso parte ad alcune proteste e mi hanno arrestato. Fa male raccontare le nostre storie ma devono venire fuori. Visto che, purtroppo, le notizie reali sono filtrate dai media, la testimonianza di chi le ha vissute è tutto ciò che abbiamo». All’università di Torino Asem ha frequentato il primo anno di Comunicazione interculturale, poi è arrivata l’occasione di Powercoders grazie alla segnalazione del tutor dello Spraar che aveva colto il suo interesse per l’IT. «All’accademia si lavora duramente per otto ore al giorno» ci racconta.
È tutto molto organizzato, non hanno dimenticato nulla. Dopo il corso io ho fatto un tirocinio di sei mesi per Aubey e dopo mi hanno fatto un contratto di apprendistato di tre anni. Davvero una possibilità unica
Il trentenne Gando Diallo sta partecipando all’edizione milanese 2021. Viene dalla Guinea ed è arrivato in Italia quattro anni fa. Gli è stato riconosciuto lo status di rifugiato politico e, dopo avere girato diverse cittadine, ora vive a Rimini. «In Guinea mi sono laureato in programmazione informatica. In Italia, ho fatto il corso di alfabetizzazione e poi ho lavorato come magazziniere e rider. Ora con Powercoders ho a che fare con una materia che conosco, posso migliorare e aggiornarmi. Sono molto soddisfatto perché ho sacrificato tanto per studiare e non vorrei perdere tutto il lavoro fatto». Gando aggiunge parole di gratitudine per avere ricevuto una borsa di studio perché tanti, come lui, hanno un patrimonio di buona volontà ma non possono permettersi un corso di questo tipo. «Sono riuscito a prendere anche la patente. Quando vedo una buona opportunità ci metto il cento per cento di impegno per non farmela scappare e per non far perdere soldi a chi investe nel progetto».