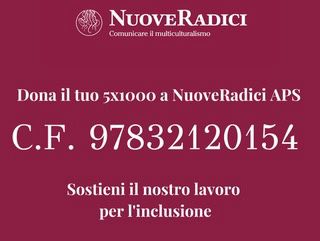Lo aveva capito anche Alberto Sordi, trafficante d’armi in un memorabile film del 1974: “Finché c’è guerra c’è speranza”. Lo abbiamo capito tutti nel bel mezzo della guerra in Ucraina, scatenata dalla feroce invasione dell’esercito russo, che le armi, finché ci sono, non fermano certo la guerra e allontanano ogni tentativo di aprire un processo di pace. In questo Crisi globali e affari di piombo, pubblicato dalle Edizioni Seb27, la giornalista Futura D’Aprile, esperta di medio Oriente e di export di armi, analizza le conseguenze che il mercato mondiale delle armi, sempre più in espansione, ha non solo sui teatri di guerra. A partire dalle migrazioni che inevitabilmente costringono le popolazioni a fuggire dai conflitti, in cerca di una pace duratura. È successo nel Corno d’Africa, in Bosnia, in Sudan come in Ruanda, in Afghanistan come in Siria, recentemente in Ucraina. E di volta in volta abbiamo assistito a una Unione Europea sempre più schizofrenica, pronta ad alimentare il mercato delle armi assai goloso ma allo stesso tempo incapace di gestire i flussi migratori, se non con politiche di contenimento o molto spesso di respingimento. In ballo ci sono miliardi, in euro. Il made in Italy, soprattutto sulle armi leggere lo skill italiano è riconosciuto nel mondo, nel settore della guerra tira come non mai. Lo Stato, o meglio i governi che si sono succeduti negli anni, considerando strategico il settore della Difesa, lo sostengono e gli fanno scudo per non esporlo alla volatilità del mercato. L’inasprirsi del conflitto bellico ai margini dell’Unione Europea ha spronato i parlamenti a votare deroghe all’export in zone di guerra e l’innalzamento delle spese militari, cosicché mentre in Ucraina, come in Yemen o in Libia i civili subiscono le terribili conseguenze della guerra, i profitti delle holding di tutto il mondo continuano indisturbati la loro scalata. Aiutarli a casa loro, un vecchio slogan provo di significato, oggi viene tradotto con l’invio di armi sempre più efficienti e costose su ogni teatro di guerra. Spesso in barba alle legislazioni nazionali ed europee. Senza pensare, o non volendo affatto pensare, che ogni pallottola venduta per alimentare una guerra non può che far aumentare le fughe dai conflitti dei civili che si riversano in Occidente. Fabio PolettiFutura D’AprileCrisi globali e affari di piomboPolitica e industrie italiane nel mercato internazionale delle armi da guerraprefazione Alex Zanottelli2022 Edizioni Seb27pagine 128 euro 15

Per gentile concessione dell’autrice Futura D’Aprile e delle edizioni Seb27 pubblichiamo un estratto dal libro Crisi globali e affari di piombo.La narrazione secondo cui il rafforzamento della potenza militare di un Paese corrisponda inequivocabilmente a una maggiore sicurezza interna e nell’area di riferimento non tiene conto delle lezioni del passato (e del presente). Guardando alle politiche messe in atto dagli Stati europei negli ultimi anni, è possibile notare come la vendita di armamenti a Paesi coinvolti in teatri bellici e che rivendono o cedono il materiale acquistato abbia finito con l’alimentare guerre e conflitti, contribuendo pertanto all’instabilità di determinate aree del mondo. Un’instabilità che si traduce anche nell’aumento delle migrazioni forzate, le cui direttrici puntano con crescente frequenza verso il Vecchio continente.Ma la risposta dell’Europa a quella migrazione forzata che concorre essa stessa a creare si è tradotta raramente in progetti di accoglienza. L’Unione – sia collettivamente che a livello di singoli Paesi – ha investito denaro pubblico nel rafforzamento delle frontiere esterne e nella gestione dell’immigrazione, garantendo un ingente ritorno economico alle aziende della Difesa. Negli ultimi anni, questo settore ha assistito a un costante aumento dei profitti e si prevede un’ulteriore crescita entro il 2025 pari a 65-68 miliardi, grazie anche al denaro europeo.Tra il 2014 e il 2020, l’Unione Europea ha infatti destinato 2,4 miliardi di euro al Fondo ue per la sicurezza interna, tra le cui prerogative rientrano anche la gestione integrata delle frontiere e il loro rafforzamento, 3 miliardi al Fondo asilo, migrazione e integrazione (amif) e altri 2 a Frontex, l’agenzia europea della guardia di frontiera e costiera più volte accusata di violazione dei diritti umani3.Il bilancio pluriennale per il 2021-2027 non fa che confermare l’interesse dell’Unione verso la securitizzazione dei propri confini. Bruxelles ha previsto una spesa di 25,7 miliardi di euro per la gestione dell’immigrazione e dei confini, mentre Frontex ha ottenuto un budget di 5,6 miliardi di euro, il più alto di sempre. A ciò si aggiungono anche i 7,9 miliardi di euro che saranno destinati nei prossimi sette anni al Fondo europeo di Difesa (edf), creato per coordinare e accrescere gli investimenti nazionali nella ricerca per la Difesa e per aumentare l’interoperabilità tra le forze armate dei Paesi membri. Questo stesso fondo è stato usato per la prima volta a febbraio per coordinare l’invio di armamenti in Ucraina da parte degli Stati europei, andando ancora una volta ad avvantaggiare le aziende della Difesa.Ma il bisogno dell’Europa – e dell’Italia – di fermare i flussi migratori ha anche costretto Bruxelles a stringere accordi con Paesi che violano quegli stessi valori di democrazia e rispetto dei diritti di cui l’Unione si fa promotrice a livello internazionale. Tra questi rientra per esempio la Turchia, a cui l’Europa ha già versato 6 miliardi di euro per trattenere i migranti nel suo territorio e verso cui saranno presto diretti nuovi fondi. La scelta di pagare Ankara per fermare i flussi migratori ha messo però l’Unione Europea in una posizione difficile: il Governo turco ha più volte utilizzato la carta migratoria per ricattare l’Europa e per evitare che Bruxelles reagisse in maniera decisa contro la politica estera espansionista del presidente Recep Tayyip Erdogan e contro la continua erosione dei diritti politici e civili nel Paese.Ma a beneficiare della securitizzazione dei confini esterni dell’ue è anche la Guardia costiera libica, che ha continuato a essere finanziata ed equipaggiata dall’Italia nonostante le documentate violazioni dei diritti umani. Anzi, i soldi investiti da Roma sono persino aumentati, essendo passati dai 3,6 milioni del 2017 ai 10,5 del 20216.Gli ingenti investimenti nel rafforzamento dei confini esterni vanno però di pari passo con la vendita di armamenti da parte dell’Italia e degli altri Stati dell’Unione a Paesi in conflitto o che governano con il pugno di ferro, Paesi da cui la popolazione continua a fuggire facendo rotta molto spesso verso l’Europa. Il nesso tra vendita di armi e immigrazione però sembra non sia stato ancora colto in Europa, così come si continua a ignorare quanto spesso il rafforzamento dei confini si sia dimostrato una risposta inadeguata al bisogno di sicurezza degli Stati.