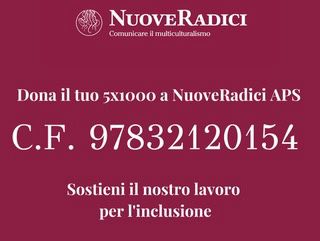Ha un anno di vita la legge 47, che detta le misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati: 13.838 migranti sotto i 18 anni privi di adulti di riferimento (il dato si riferisce a una rilevazione del 31 marzo scorso, a febbraio 2017 erano 14.338, 18.303 a dicembre 2017). Ragazzini o adolescenti, quando non poco più che bambini, in fuga dalla propria casa e dal proprio Paese per cercare altrove un futuro migliore per sé o per la propria famiglia di origine. La legge 47 è innervata dal principio sancito dalla Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, proclamata a New York e ratificata dall’Italia nel 1991, secondo la quale un bambino è prima di tutto un bambino e per questa ragione ogni decisione che lo riguardi deve essere ispirata al criterio del suo “superiore interesse”. In quanto tale la sua persona, la sua integrità, la sua vita, i suoi diritti sono rispettati senza alcuna discriminazione in ragione della sua condizione. Ma la legge, nata da un confronto con la realtà e con quanti sono chiamati a gestire il fenomeno dei cosiddetti msna, minori stranieri non accompagnati (che si è imposto in forza dei suoi numeri a partire dalle cosiddette Primavere arabe), è attraversata dall’ambizione di essere «Uno strumento di trasformazione, di modificazione delle regole del gioco, delle mentalità, dei costumi e delle istituzioni, di innovazione e creatività» e muove dalla certezza che il diritto «non è solo lo strumento con il quale si resiste al cambiamento, ma è anche lo strumento con il quale lo si accoglie e, auspicabilmente, lo si favorisce» (Annalisa Furia, “Prima i bambini”, in Il Mulino, aprile 2017). Il fenomeno migratorio e di un numero sempre maggiore di giovani e giovanissimi va affrontato con una visione non emergenziale, non securizzata o peggio ancora criminalizzante, ma con una visione di lungo periodo, e con la capacità di immaginare la società del futuro e di introdurre nel suo funzionamento elementi innovativi. L’arrivo di ragazzi e ragazze in un Paese che soffre un declino demografico spaventoso come l’Italia può e deve diventare una opportunità: occorre dunque che alla semplice accoglienza si accompagni un progetto di vera inclusione tale da far maturare un senso di autentica cittadinanza nei giovanissimi migranti.
Da qui sono scaturite nella legge alcune novità rispetto alle più tradizionali forme di gestione del fenomeno migratorio: l’introduzione della figura del tutore volontario e quella dell’affido familiare. Due vere e proprie innovazioni che chiamano la società civile a partecipare al cambiamento e ad assumersi una responsabilità rispetto a ciò che la circonda. Perché affidare a un tutore volontario la cura e la sorveglianza di un minorenne che ha lasciato alle proprie spalle quel po’ di sicurezze e di punti di riferimento che la vita assegna, ovvero il padre, la madre, fratelli e sorelle, amici, la casa, la comunità di origine? Per far maturare uno scambio non solo culturale e affettivo, utile ad accompagnarne una integrazione piena nel nuovo Paese d’arrivo e allo stesso tempo in grado di dotare il sistema di una rete di vere e proprie sentinelle che controllano e valutano la qualità dell’accoglienza in tutti i suoi aspetti: dalla struttura della comunità dove questi ragazzi vengono collocati alla qualità dell’offerta formativa o dell’accesso alle cure. Straordinaria, ad oggi, è stata la risposta dei cittadini ai quali è stata rivolta la proposta di diventare tutore. Secondo i dati raccolti dall’Autorità garante dell’infanzia e dell’adolescenza, sono 4.000 le persone che hanno dato la propria disponibilità a diventare tutore. Una parte di loro, in maggioranza donne tra i 35 e i 45 anni scolarizzate, hanno già frequentato i corsi di formazione previsti per esercitare questa forma di “cittadinanza attiva”. Ma per estendere e far crescere il numero dei tutori (è evidente che il risultato ideale dovrebbe prevedere la nomina di un tutore per ogni ragazzo) vanno assunte alcune misure come polizza assicurativa e permessi lavorativi necessari allo svolgimento delle proprie funzioni. Fare decollare l’istituto dell’affido familiare dipende invece soprattutto dell’impegno di Anci, ma anche delle Regioni. Proprio in ragione della istituzione della figura del tutore la legge ha chiuso una procedura di infrazione aperta in sede Europea nei confronti dell’Italia. Grave risulta perciò la mancata assunzione dei decreti attuativi relativi ad altre parti della legge, che rischiano di restare inattuate o di essere attuate a macchia di leopardo nel Paese. Le nuove norme sono state oggetto di attenzione in sede internazionale (basti pensare al Rapporto Unicef Beyond borders: How to make the global compacts on migration and refugees work for uprooted children), a partire da quella europea, dove attualmente si valuta la possibilità di estendere la sperimentazione dei tutori volontari agli Stati membri come indicato dal vicepresidente della Commissione UE, Timmermans, secondo il quale «Le strutture e le procedure per l’accoglienza sono molto migliorate» in questi anni in Italia. «Basti pensare alla legge Zampa (la legge 47, n.d.r.), che, se ben applicata, ha il potenziale di essere un esempio per molti Paesi». Sarebbe assai grave se dovessimo prendere atto, magari tra un anno, che una legge che riconosce all’Italia il primato in una materia così sensibile rimarrà sostanzialmente inattuata.
*Sandra Zampa è stata parlamentare del Partito democratico, autrice della legge 47/2017 , ed è ora consulente Cidu (Comitato interministeriale diritti umani)