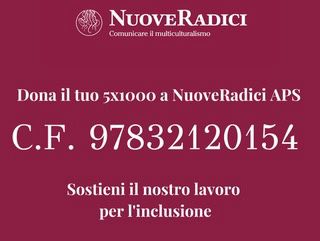Shi Yang Shi, scrittore e attore emergente italo-cinese, ci ha mandato un testo travolgente come la sua arte.
(foto di Alberto Pelayo)
Lo spettacolo “Arle-Chino: traduttore e traditore di due padroni”, spettacolo teatrale in tre parti, è nato nel 2014 a Prato. Il testo l’ho scritto con Cristina Pezzoli che ne ha curato la regia. Era uno dei progetti che questo spazio teatrale indipendente di Prato ha prodotto per sette anni, fino a febbraio 2016. Il testo è frutto della mia storia autobiografica. Nella prima parte dello spettacolo ho ricostruito le storie dei miei antenati, con personaggi anche nemici tra loro. La seconda parte racconta la mia riprogrammazione culturale e nella terza l’elaborazione del lutto della morte di sette operai cinesi a Prato il primo dicembre 2013, nel rogo di una fabbrica, producendo Made in Italy.
Il progetto di ricerca era nato molti anni prima, nel 2009, per rielaborare i cosiddetti cadaveri culturali italiani, cioè fatti storici fondamentali per la storia del Paese. Andando a ritroso, lo sono stati Tangentopoli, gli anni di piombo, il fascismo, fino alla nascita dell’Italia con il Risorgimento. Interrogandoci sul perché fosse in atto un periodo decadente dell’italianità. Negli anni in cui abbiamo cominciato la ricerca, la regista Cristina Pezzoli, la drammaturga Letizia Russo ed io insieme a moltissimi altri attori, scrittori, poeti, registi e storici abbiamo animato l’intero progetto teatrale per sette anni.
Perché Prato? Perché Prato, nel 2009, aveva la dimensione più adatta per osservare da vicino i vari meccanismi di conflitto, per poi raccontarli. Io ero uno strumento, in quanto cittadino italiano nato in Cina, per osservare questi conflitti. In città tra cinesi ed italiani c’erano grandi difficoltà di convivenza e abbiamo anche coniato titoli di incontri di ascolto come “via i cinesi da Prato”. Per un intero anno, noi artisti, chiedendo aiuto a dei sociologi e a Marianella Sclavi, antropologa specializzata nella gestione creativa dei conflitti, abbiamo condotto dieci incontri di “Sono qui perché”. Tantissimi cittadini hanno partecipato, a partire dai cinesi, e si sono raccontati attraverso lo strumento dell’AntroPolaroid. Il mio spettacolo è nato dopo questo anno di ricerca e di ascolto, ed ha rappresentato in città la possibilità per tanta gente di conoscersi più da vicino e di confrontarsi per la prima volta. Ed è nato perché io volevo raccontare i conflitti tra le persone, tra le comunità.
Cristina Pezzoli invece mi disse: «Devi prima raccontare i tuoi conflitti interiori, i tuoi pezzi di identità». Da allora, la sua azione maieutica mi ha insegnato come fare domande ai vivi per recuperare tramite loro la memoria dei morti, la storia della mia famiglia di origine. E quindi nello spettacolo c’è la mia bisnonna materna, che da bambina venne “torturata” per far crescere i suoi piedi deformati e piccoli, 10 centimetri, che si chiamavano “loto d’oro”; oppure il mio bisnonno, che a trentasette anni ha sacrificato la vita gettandosi contro i nemici giapponesi per difendere i suoi ideali comunisti. La mia trisavola materna, che all’inizio del ‘900, rimasta vedova a quarant’anni, aveva reso famosi gli spaghetti di soia fino a Hong Kong. Ma anche il conflitto, simile a partigiani e fascisti, nella mia famiglia d’origine, tra mio nonno materno, che aveva studiato con gli americani negli anni Trenta diventando medico e per questo fu torturato per dieci anni dal regime comunista e mio padre, che a diciannove anni era una “guardia rossa” e aveva l’ideale di una Cina finalmente in piedi rispetto alle altre nazioni del mondo, grazie al suo grande Mao. A tutto questo, ho aggiunto il racconto della mia “riprogrammazione culturale”, con l’arrivo in Italia e l’apprendimento delle sue regole e della sua cultura. La mia trasformazione in ragazzo pestifero che non era più il primo della classe, per poi tornare ad esserlo dopo l’esperienza di lavapiatti in Calabria, dove capisco che imparare e studiare poteva permettermi di cambiare vita. Quando ero bambino in Cina a chi mi faceva la domanda “Cosa vuoi fare da grande?” rispondevo senza esitazione: pittore. Arrivato a undici anni a Milano, la vita invece cambiò così drasticamente che neanche i miei genitori avevano la possibilità di gestirla. Nello spettacolo ci sono i miei sette anni da vu cumprà nelle spiagge adriatiche e, nello stesso tempo, l’essere un bocconiano e scoprire che il mio sogno era fare il teatro ed essere bocciato alla scuola di recitazione Paolo Grassi, per poi approdare alle Iene. È il linguaggio tragicomico, quello che abbiamo scelto, per raccontare il conflitto tra gli stereotipi degli italiani che accusano i cinesi di essere la causa di tutti i mali della crisi italiana e dall’altra quelli dei cinesi che, con altrettanta arroganza, accusano gli italiani di lavorare poco, solo otto ore, dimenticando che i loro padri si sacrificavano come fanno ora i cinesi per le loro famiglie.
Dallo spettacolo, nasce il libro Cuore di seta. Mondadori mi propose di scrivere il libro nel 2015, ed io all’inizio risposi di no a questa proposta. Più avanti, però, ci furono gli attentati da parte dei kamikaze in Europa, tra questi alcuni ragazzi di terza generazione. Ed in particolare mi colpirono alcuni libici, i cui genitori erano scappati dalla Libia di Gheddafi a Londra. Loro avevano sposato l’ideologia dell’Isis per scelta identitaria, in una crisi di quei valori democratici ed occidentali a cui i miei genitori mi hanno portato con l’immigrazione in Italia. Non penso che i cinesi possano diventare dei kamikaze, però sentivo la necessità e la responsabilità di tradurre in un racconto scritto quella che era la mia storia, riportando in parte ciò che era già stato usato nello spettacolo, ma facendo anche per la prima volta coming out.
Senz’altro una punta del mio “seme biforcuto” è legata all’orientamento sessuale, e nella sessualità c’è sempre il rapporto col potere. Parte di questa ultima storia non è stata volutamente raccontata nel libro, perché non ero pronto e sarebbe stato troppo lungo. Gli editori volevano un libro che fosse tenero con i ragazzi a cui si rivolgeva, gli young adults, quella classe di adolescenti che in Italia va dai tredici fino ai trent’anni. Posso concludere così: penso che il mio raccontarmi sia, in questo momento, la sintesi di un’Italia che si rivela. Un’Italia che scopre di avere tante radici, a volte impresentabili, a volte scomode, che si intrecciano senza essere della stessa specie e della stessa misura, e a volte si fanno sgambetto l’una con l’altra, per trovare terreno su cui attecchire. Lasciare perdere tutte queste radici sembra un’impresa impossibile. Quelle roots che sono il passato, personale o familiare, collettivo o addirittura mondiale, dell’umanità. Quella ricerca delle radici (寻根, xun gen, pronuncia tipo: siun ghen) a cui siamo chiamati.
Per rimanere in tema di radici, esiste anche un albero gigante all’interno del parco di Porta Venezia a Milano, vicino alla statua di Indro Montanelli, dove io mi reco spesso per fare dei giri in senso orario, come avviene nelle preghiere nei luoghi sacri buddhisti, ad esempio intorno allo Stupa a Kathmandu. A volte scavalco i recinti e mi butto su uno di quei rami giganti a mo’ di leopardo pigro, canticchio e mi passa tutto.
Ogni giorno provo a ripulire il mio cervello con mantra di preghiere, incensi e prostrazioni dedicate a Buddha, nel tentativo di imparare a concentrarmi sulla parte più originale di me: quel cuore fiorito diamantato, indistruttibile, gioioso e contagioso.
E questa è solo la premessa.
Ahah, la mia arte è diventata una bella premessa! Olè!
tayata om bekhadze bekandze maha bekandze bekandze radza samudgate soha
(questo mantra del Buddha della Medicina è tra i tanti che recito cantando tutti i giorni per combattere veleni mentali come rabbia, ignoranza, attaccamento al desiderio. E quindi, abbasso anche l’attaccamento alle radici…)